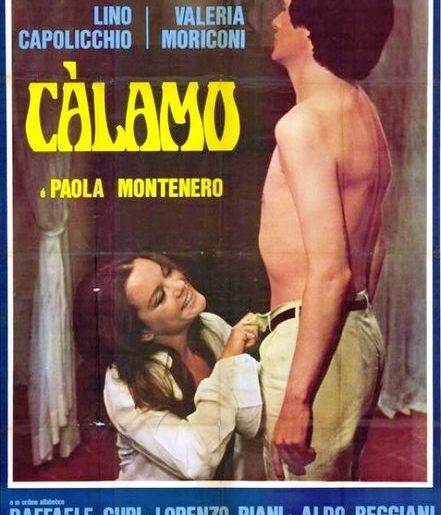L’innocenza perduta nell’odio immorale della famiglia borghese e la tartaruga dipinta di giallo.
Simona, vede usurpato il suo ruolo di “amante del mostro” e agisce di conseguenza: ingaggia con la madre un duello estremo che la porta persino a concedersi sessualmente ad un attonito Federico. Nel bagno – nascosto dalla furia dei rangers che vogliono ucciderlo – egli subisce la provocazione di Simona, che si sdraia nuda sul tappeto dicendogli: “Allora cosa aspetti…o hai paura di Vera”. In una scena che non lascia niente all’immaginazione – ma che appare incredibilmente pura – Federico possiede Simona rinnegando (o trasformando) quel ruolo di “mostro” finora assunto per diventare un ridicolo (e impossibile) amante affettuoso e premuroso. Simona continua a studiare le mosse della madre e si ritrova a spiare l’amplesso tra lei e Federico. Sentendosi tradita, piena di astio e rancore, si reca al commissariato per denunciare entrambi. L’uomo di legge ottiene da Vera la possibilità di arrestare Federico, e per non denunciarla per complicità, baratta con lei un rapporto sessuale: “Ci si può mettere d’accordo su qualunque cosa e a qualunque prezzo”.

Nel finale, Simona scopre il suicidio del padre, prende una pistola e uccide a freddo il commissario e la madre mentre sono a letto, per poi liberare Federico e allontanarsi con lui mano nella mano. Il lieto fine fiabesco sembra trionfare, non attraverso la consueta uccisione del cattivo, bensì tramite la sua “trasformazione”, e non a caso è lo stesso Federico che, mentre si allontana dalla villa con Simona, dice: “Arriva sempre il momento di partire. Molto più in là del parco, dove l’erba cambia colore e incominciano le strade, quelle grandi. Prenderemo quelle”. Ma l’uomo – ignaro della sorte riservatogli da Simona – non coglie l’ironia glaciale con cui la bambina gli risponde: “È là che mi aspettano… quelli della mia età”.Federico entra nella grande voliera e scherza con la bambina/donna che, silenziosa, mentre lui si arrampica, prende la mira e lo uccide facendolo precipitare al suolo come se fosse un uccellino.

Massimo Pirri, non ha mai concepito il lieto fine per il suo cinema, né tanto meno ha cercato una conciliazione con il pubblico ma ha sempre messo in pratica (conoscendola o no non ha importanza) la posizione di Theodor Adorno sull’happy ending cinematografico:Il cinema del lieto fine non prende posizione sul mondo, non pensa alle vittime della storia, non fa altro che generare un mondo illusorio sul quale acquietarsi.[1]; questo perché il suo cinema vuole essere disturbante, trasversale ai generi e alle classificazioni.

La Vigevano de L’Immoralitàè archetipo di quella provincia opulenta, bigotta e ostinatamente padronale che nel Nord industrializzato ha lentamente sostituito i valori di solidarietà, fratellanza e rispetto reciproco con una strisciante ed espandente immoralità latente fatta di individualismo, sfruttamento e silenzio. La “cultura del silenzio” che domina il film di Pirri appare pertanto congeniale alla metafora della grande voliera vuota, dove gli uccelli in gabbia sono i personaggi stessi, rappresentativi di una provincia al collasso in cui il “mostro” diventa normale e dove i “normali” nascondono la natura di “mostri”. Chiusi nelle loro case (la villa), spaventati dal prossimo e dal diverso, educati dalla tv (che da b/n passa a colori), schiavi del culto del denaro, gli abitanti della provincia coltivano, inconsciamente, il morbo dell’immoralità, tramandandolo di madre in figlia come arma di difesa verso un mondo che non riconoscono e da cui vogliono staccarsi con qualunque mezzo, consapevoli del fatto che sono loro stessi a crearlo.

La grande voliera diventa quindi allegoria di un mondo – sostituivo di quello contadino – basato sul profitto e sulla sopraffazione (anche all’interno della famiglia stessa), teso, irrimediabilmente, all’accumulo e all’ostentazione della ricchezza – elemento necessario a determinare lo status sociale. L’illusione eterna di voler “esser libera” (come dice Vera) non esiste, è un alito di vento che spazza via la felicità per far posto al rancore e all’invidia: i personaggi de L’Immoralitànon sorridono mai. Quello del film è uno spaccato dove il nemico interno diventa proiezione esterna del diverso. L’immoralità è un cancro, le cui metastasi nascono nel secondo dopoguerra, ma è con la fine degli anni ’60 e con l’arrivo del benessere successivo che la malattia sedimenta nel corpo di un Italia che ha bruciato le potenzialità di diventare civile, per cominciare ad essere quel paese mancato, abbruttito e degenerato che L’Immoralitàe il suo regista descrivono con lucida e inquietante profezia.
[1]Alessandro Alfieri, Benjamin, Adorno e la contemporaneità, in CineCritica n.50/51, Aprile-Settembre 2008, pag.64
di Fabrizio Fogliato
L’IMMORALITA ’(1978)
Regia/Director: Massimo Pirri
Soggetto/Subject: Massimo Pirri, Federico Tofi, Morando Morandini
Sceneggiatura/Screenplay: Massimo Pirri, Federico Tofi, Morando Morandini
Interpreti/Actors: Lisa Gastoni (Vera), Karin Trentephol (Simona, figlia di Vera), Renato Rossini [Howard Ross] (Federico Anselmi), Mel Ferrer (marito di Vera), Andrea Franchetti (tenente di polizia), Wolfango Soldati (Antonio, un giustiziere), Francesco Ferri (amico), Deborah Lupo, Ida Meda
Fotografia/Photography: Riccardo Pallottini
Musica/Music: Ennio Morricone
Costumi/Costume Design: Sergio Palmieri
Scene/Scene Design: Sergio Palmieri
Montaggio/Editing: Cleofe Conversi
Suono/Sound: Piergiuseppe Ghezzi
Produzione/Production: Ducale Film, Una Cinecooperativa
Distribuzione/Distribution: Una Cinecooperativa
censura: 72568 del 08-11-1978
Altri titoli: Perché Simona