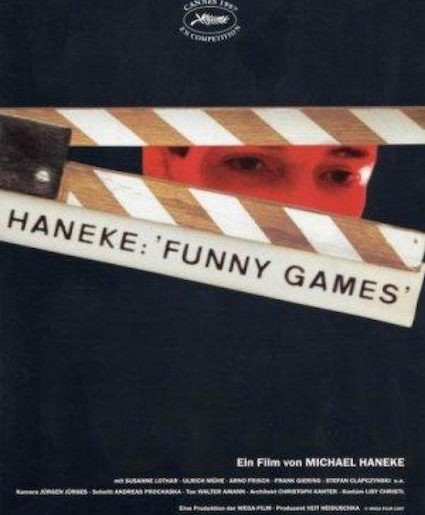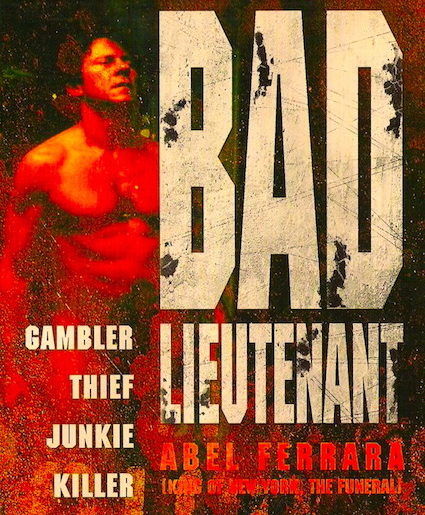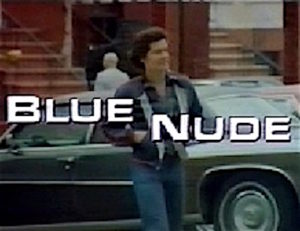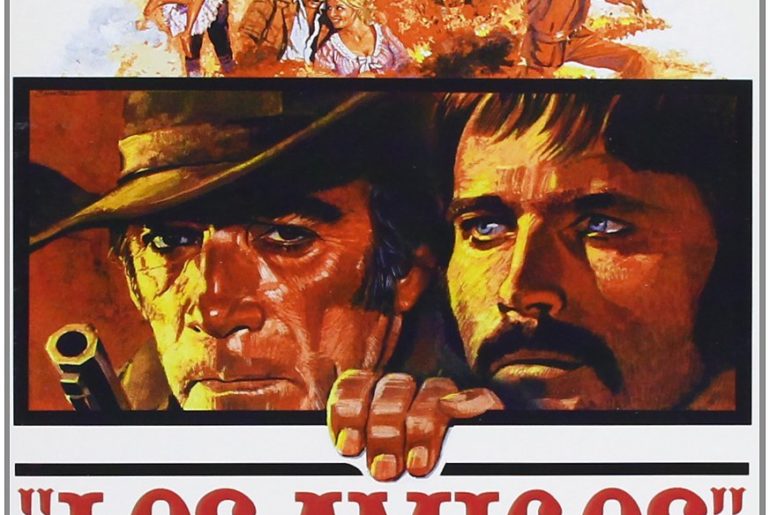E Dio disse a Caino: guarda come ti ammazzo una star della televisione
Il sesso e la sua consumazione, orgiastica e seriale, l’accumulo di corpi femminili ogni volta diversi e sempre uguali, si susseguono nella vita di Crane, il quale preso nel delirio di onnipotenza garantitogli da Hogan’s heroes, tenta di riprodurre e replicare all’infinito i suoi incontri sessuali rendendoli “eterni” attraverso l’impressione su nastro e prodigandosi in un lavoro/dipendenza in cui colleziona polaroid che certificano le diversità dei caratteri sessuali delle donne che incontra, focalizzando prevalentemente la sua attenzione sul seno (come testimonia il “montaggio sequenziale” in cui Schrader mostra seni di ogni tipo, età ed epoca, come a voler rappresentare un tipo di maschio esistente da sempre). Bob Crane, è affetto da una solitudine persistente e patologica, ed è chiuso in un concetto di sessualità infantile e coatto, come dimostra la scena della consumazione onanistica degli home movies pornografici da parte di John e Bob nella taverna della casa di Patty. Il suo dunque, nell’ottica integralista e calvinista di Schrader è un “peccato mortale” perchè legato al raggiungimento di un piacere vuoto e momentaneo, slegato da qualsivoglia implicazione sentimentale: stando così le cose appare quasi inevitabile, quindi, che l’espiazione della colpa passi attraverso la morte. La morte “di finzione” di Bob Crane mostrata in Autofocus, non è molto dissimile da quella documentata dalla sua biografia e testimoniata dalle vicende seguenti il ritrovamento del suo cadavere.

Nell’edizione finale del film, Paul Schrader ha (giustamente) eliminato la scena in cui viene mostrato il ritrovamento del corpo esanime di Crane da parte di Victoria Berry, sua compagna di lavoro nella piece teatrale Beginner’s Luck. Nel momento in cui la donna entra nell’appartamento, ancora ignara dell’accaduto, è testimoniata tutta la parabola auto-distruttiva dell’attore, e il luogo stesso (l’appartamento al Windfield Complex) assume valore metaforico nella sua “messa in scena” scenografica. Nel documentario Murder in Scottsdale (id., 2001) di David Naylor il ritrovamento del cadavere di Bob Crane, alle 13.00 del 29 Giugno 1978 è raccontato con dovizia di particolari dalla viva voce di Stephen Avilla, l’avvocato difensore di John Carpenter e da quella di Jim Raines, all’epoca procuratore della contea di Marcopa: “L’appartamento è completamente buio, non si riesce a vedere all’interno senza accendere la luce. Crane aveva messo delle tende molto scure per nascondere tutta la pornografia che aveva e le fotografie cui stava lavorando, oltre che nascondere quello che faceva giorno e notte con le donne che portava lì. Quindi, quando Victoria apre la porta, passa dalla luce accecante del sole dell’Arizona alle 13.00 del mattino alla stanza buia dell’appartamento di Crane. Entrata, si chiude la porta alle spalle. A quel punto è estremamente buio e lei non accende la luce. Chiama Bob ma non riceve risposta, si addentra ulteriormente nell’appartamento e nota che la porta della camera da letto è socchiusa. E’ tutto oscurato. Le tende sono tirate. Si avvicina alla porta, guarda dentro e vede il contorno indistinto di qualcuno sul letto. Si avvicina convinta che si tratti di una donna visto che la zona della testa è più scura. A quel punto nota che si tratta di sangue, sangue coagulato”.

Gli agenti intervistati nel documentario parlano di una scena del delitto caotica in cui c’è gente che fuma, che telefona. Scottsdale è un piccolo centro di provincia, e la polizia di non è abituata agli omicidi di celebrità, così si trova per le mai un caso più grande di lei, difficile da gestire e da controllare. Gli indizi conducono a John Carpenter come principale indiziato, ma né le indagini del 1978 né quelle di dieci anni dopo ordinate dal nuovo procuratore della contea di Marcopa Richard Romley, che fa riaprire le indagini anche per interessi politici ed elettorali, portano alla soluzione del caso. Nel 1988 John Carpernter va a processo, un processo indiziario, che si risolve con la soluzione dell’imputato che successivamente muore di infarto all’età di settantadue anni. Ma questa parte processuale non interessa al regista, che concentra la propria attenzione sulla parabola esistenziale del protagonista. Paul schrader, attraverso il racconto dell’ascesa e del declino dell’attore, ambisce a costruire la rappresentazione, distonica e alterata, dell’ “American way of life”; lo fa frammentando e distruggendo il concetto di successo (e della presunta felicità ad esso collegato), inteso come mitizzazione dell’individuo (e di conseguenza spersonalizzazione dello stesso). Bob Crane, una volta divenuto popolare, impara a costruirsi una identità fittizia e onnipotente in cui convivono, contemporaneamente, il buon padre di famiglia (premuroso con i figli e pacato con la mogli) e il dipendente dal sesso (onnivoro e insaziabile). Il sesso nella vita di Bob Crane agisce da moneta di scambio per affermare (comprare) la propria personalità: faccio sesso con centinaia di donne che vengono con me solo perchè sono Bob Crane, quindi esisto non solo come immagine. Anche durante gli amplessi, in fondo, Crane non fa niente altro che interpretare una parte, quella che lui stesso si è cucito addosso, evocata già dalla voce-off in prima persona che chiude la prima scena del film: “Io ho sempre voluto farmi notare. Avete presente il tipo no? Ce n’è uno in ogni classe: lo sbruffone. Eddie Cantor mi disse che piacere è già il 90% dell’opera… e aveva ragione. Beh! Quello sono io. Un tipo che piace”.

L’edonismo, l’apparire , il “piacere” (inteso anche come stato di estasi sessuale), vengono dipinti da Schrader come qualcosa di momentaneo, legato al concetto filosofico di “permanenza del possibile”, uno stato transitorio che non conduce mai alla felicità perchè (come la pornografia) la rimanda di orgasmo in orgasmo. La trappola schraderiana in Atofocus, non è orchestrata sulla superficie di un desiderio sessuale patologico, ma è rappresentata da qualcosa di ben più profondo, di intangibile e sfuggente come il “peccato originale”; che si tratti di qualcosa di intimo e religioso, slegato sia dalla carriera che dal mestiere di attore (con relativa popolarità annessa) è testimoniato dalla presenza, nelle scene iniziali del film, di Bob e sua moglie Anne, in chiesa durante la messa, e le parole, pronunciate dal prete, che chiudono la scena sono appunto: “…E tornerà nuovamente per giudicare i vivi e i morti”. La tentazione si fa carne con il proseguire del film, il giudizio divino è sempre immanente, e l’edonismo patologico di Bob Crane viene trasfigurato in un perverso gusto del piacere onanistico: il suo egoismo implica che la partner di turno, non sia altro che carne, uno strumento per il suo piacere, privo di volontà, sentimenti, ed emozioni. La morte è un sacrificio necessario per mondare i propri peccati e per espiare la colpa primordiale; condizione accentuata, nel film, dalla pena del contrappasso che porta Crane ad essere ucciso con un treppiede per macchina fotografica: lo strumento di piacere che si fa strumento di morte La morte porta con se anche la fine della propria immagine nella realtà ma non nella finzione, infatti, la riproducibilità delle immagini, la loro continuità rappresentata dai nastri del VTR permettono la prosecuzione della vita di fiction e legano l’occhio dello spettatore con quello meccanico della cinepresa e con l’immagine amatoriale riprodotta.


Paul Schrader, in Autofocus, costruisce un percorso “visivo” in cui la dualità e l’anomia di Bob Crane si esplicano attravrso l’indistinta rappresentazione delle immagini da lui riprese: senza soluzione di continuità egli passa da riprendere le immagini di vita familiare (i bambini che giocano sul tappeto, la moglie che lava i piatti), a farsi riprendere dall’amico e sodale John Carpenter mentre una donna gli pratica una fellatio (oltre ad orge, e ogni prestazione sessuale da lui consumata). Quando si rivede nell’uno come nell’altro caso, la soddisfazione sul suo volto è la stessa: per lui non c’è alcuna differenza perchè l’importante è rivedersi (e in questo Crane rappresenta un antesignano del narcisismo oggi imperante nell’industria dell’immagine), stare davanti ad una videocamera o ad una macchina da presa, sorridere all’obiettivo, ammiccare, sedurre plasmare i propri spettatori. Non è casuale che per converso e con non poche implicazioni e ambiguità di carattere omosessuale, John Carpenter replichi a Crane dicendogli che invece lui preferisce stare dietro la macchina da presa o la videocamera, perchè ogni attore, per esistere, ha bisogno di un operatore/regista, così come ogni narciso dello specchio, perchè quello che conta è affermare la propria immagine, esistere per piacere (anche solo a se stesso). “La famiglia prima di tutto…E’ certo più importante di un qualsiasi programma televisivo” chiosa Crane di fronte alle perplessità della moglie riguardo al recitare in un serial comico sull’olocausto, ma allo stesso tempo, l’inibizione imposta dalla donna al marito, descrive al meglio la condizione di repressione in cui egli è costretto per la necessità di apparire ipocritamente “normale”. Poco dopo, sempre Anne, gli rimprovera la presenza di pornografia nel garage: badando al puritanesimo di facciata, la donna non si accorge delle devianze del marito.

Che l’impianto di Autofocus sia improntato alla rappresentazione morale della scelta e del peccato è certificato dal dialogo imbarazzato tra Bob (in cerca di una possibile confessione) e il prete (conscio del problema di Bob e della sottovalutazione dello stesso) alla tavola calda, in cui mentre Crane è distratto dalle grazie di una giovane fan, il prete e amico gli intima severe: “Bisogna allontanarsi dalle occasioni di peccato”. Il voyeurismo, dunque è una occasione di peccato e in quanto tale sono colpevoli tanto il protagonista quanto il regista quanto lo spettatore, e la moltiplicazione del quadro mostrata in più scene del film ha la forte valenza morale di far riflettere chiunque guardi sulla responsabilità insita nell’atto. Durante l’incontro con la ragazza bionda e quella mora, Carpenter riprende Crane e al termine della serata gli mostra quanto fatto. Nella scena si vede Carpenter che mostra all’amico le riprese in cui si vede Bob che fotografa la ragazza mentre lei si spoglia, loro due sono sul divano e guardano le immagini sullo schermo televisivo (e in queste si vede Bob che guarda la donna attraverso l’obiettivo della Polaroid), mentre l’inquadratura oggettiva mostra allo spettatore tutta la scena: lo sguardo è moltiplicato, potenzialmente all’infinito, così come ogni immagine replica se stessa. Attraverso questo semplice espediente cinematografico la “visione morale” del regista si impone agli occhi dello spettatore e mette a confronto la sua “colpa” con quella del personaggio, il cui slogan è: “Un giorno senza sesso è un giorno sprecato”. La realtà non è più sufficiente e il peccato passa anche attraverso la riproducibilità della stessa, e la necessità è quella di essere in possesso dei supporti adeguati per poterla “controllare” (le funzioni del VTR allora e quelle del telecomando oggi) come afferma Bob Crane durante l’allucinazione sul set di Hogan’s heroes: “Non riesco a pensare ad altro che il sesso: fare sesso, filmare sesso, guardare sesso… ma non tutti hanno il proprio esperto video… tra il sesso, Patty e le checche…non riconosco più la mia vita…”
di Fabrizio Fogliato