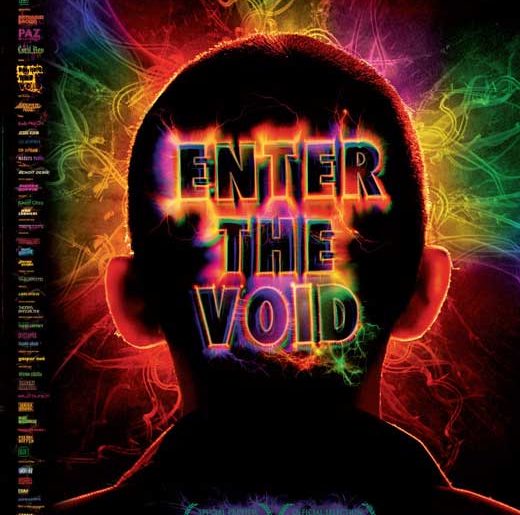Il cinema di Gaspar Noé : sondare l’indeterminatezza del visibile
Gaspar Noè, terminati gli studi, trova subito l’opportunità di girare due cortometraggi in bianco e nero: Tintarella di luna nel 1985 e Pulp amère nel 1987. Il primo è la semplice storia di un tradimento coniugale, mentre il secondo mostra un uomo che tenta di violentare sua moglie, dopo che ha sentito per radio che lo stupro può essere un atto di profondo amore: è qui, probabilmente, nasce la poetica del regista argentino. Nel 1991 Noè gira un mediometraggio di 40 min. intitolato Carne, prodotto con alcuni amici e con la collaborazione del filmaker Lucile Hadzihalilovic (autore, tra gli altri, di La Bouche de Jean-Pierre (1995), L’Ecole (2003)). Carne narra la vicenda di un macellaio di cavalli che vuole vendicarsi di un uomo, che crede, erroneamente, essere lo stupratore di sua figlia autistica. Carne, in cui l’effetto shock è costruito progressivamente attraverso l’uso di una colonna sonora marziale e con un montaggio rapido e nervoso, fin dai titoli di testa, (che in un montaggio alternato, pieno di humor nero, ci mostrano il macellaio che spacca la carne a colpi di mannaia e la ragazza autistica che guarda in televisione Blood Fest di Herschel Gordon Lewis), possiede già tutti i connotati teorici e filmici del cinema a venire di Noè, e che troveranno il loro compimento nel compiaciuto e provocatorio Irreversibile (2002).
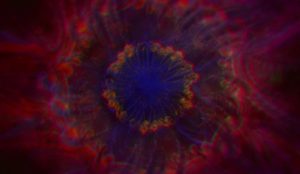 I lampi di una poetica dell’eccesso, pensata e studiata a tavolino, attraversano anche il primo lungometraggio del regista Seul contre tous (1998), lampi che fin qui hanno agito in ordine sparso, attraverso una messa in scena disordinata e provocatoria, portata avanti in opere irrisolte e recitate maldestramente che puntavano tutte le loro carte su un sensazionalismo efficace quanto posticcio. In Irreversible, invece, pur nell’ambito di una poetica provocatoria, Noè concretizza al meglio il suo apparto teorico: nel “film di coppia” Bellucci/Cassel, scimmiottando ironicamente la coppia Kidman/Cruise del Kubrick di Eyes Wide Shut (1999), il regista utilizza il genere Rape & Revenge come architrave su attorno a cui costruire un ammonimento verso una deriva societaria che porta dentro di sé violenza di classe, razzismo e primitivismo cerebrale. Elementi questi, che come una trinità blasfema, secondo Noè, si stanno sostituendo a quella Divina fatta di amore, fratellanza e solidarietà. Il senso del film, quindi, non è nel film, bensì nella sua inquadratura straziata e dolorosa che osserva il tempo irrevocabile, che frantuma ogni atto e ogni emozione. I corpi sono oggetti, e gli atti non trovano mai il loro compimento, in un film che non vuole catturare gli occhi e lo sguardo dello spettatore ma li vuole scacciare.
I lampi di una poetica dell’eccesso, pensata e studiata a tavolino, attraversano anche il primo lungometraggio del regista Seul contre tous (1998), lampi che fin qui hanno agito in ordine sparso, attraverso una messa in scena disordinata e provocatoria, portata avanti in opere irrisolte e recitate maldestramente che puntavano tutte le loro carte su un sensazionalismo efficace quanto posticcio. In Irreversible, invece, pur nell’ambito di una poetica provocatoria, Noè concretizza al meglio il suo apparto teorico: nel “film di coppia” Bellucci/Cassel, scimmiottando ironicamente la coppia Kidman/Cruise del Kubrick di Eyes Wide Shut (1999), il regista utilizza il genere Rape & Revenge come architrave su attorno a cui costruire un ammonimento verso una deriva societaria che porta dentro di sé violenza di classe, razzismo e primitivismo cerebrale. Elementi questi, che come una trinità blasfema, secondo Noè, si stanno sostituendo a quella Divina fatta di amore, fratellanza e solidarietà. Il senso del film, quindi, non è nel film, bensì nella sua inquadratura straziata e dolorosa che osserva il tempo irrevocabile, che frantuma ogni atto e ogni emozione. I corpi sono oggetti, e gli atti non trovano mai il loro compimento, in un film che non vuole catturare gli occhi e lo sguardo dello spettatore ma li vuole scacciare.

Stesso discorso portato avanti, ancor più radicalmente, con il fluviale Enter the Void, che, al contrario delle apparenze, non si basa su alcunchè di buddhista, mette la forma in evidenza sul contenuto, e al cui interno si dipana un discorso, contraddittorio, sull’utilizzo dell’artificio per raggiungere uno stato di piacere estatico, come confermano le parole dello stesso Noè: “La struttura di Enter the Void si ispira effettivamente a quella del Libro tibetano dei morti, ma noi non l’abbiamo seguita alla lettera. Gli avvenimenti che si susseguono sono la ricostruzione di quello che Alex spiega a Oscar, vale a dire le tappe del viaggio dell’anima del morto prima della reincarnazione. Ma alla fine del film si comprende come lo spirito di Oscar in realtà voli sopra un modellino di Tokyo e non della città vera. Si vede anche che Alex esce dal ventre di sua madre, quindi non si tratta di una reincarnazione. (…) Pertanto, non vi è un adattamento in senso stretto del Libro come molte persone hanno creduto, ritenendomi erroneamente buddista. Con Enter the Void ho cercato di mettere lo spettatore in uno stato ipnotico, come se si trattasse di un viaggio onirico. (…)Tokyo è una città molto più cinematografica e futurista di Parigi o New York. Come a Hong Kong, a Tokyo ci sono una quantità enorme di grattacieli che mi permettevano di far volare in continuazione la cinepresa al di sopra dei tetti. Inoltre, Tokyo permetteva una rappresentazione interessante del fenomeno della droga. Lì non si scherza affatto su tale soggetto” (Laure Charcossey, Intervista a Gaspar Noè, nocturno.it).

La vita come una spirale che si muove nel vuoto senza soluzione di continuità. L’esistenza come un cerchio in cui la vita e la morte si toccano. L’indeterminatezza del visibile mostrata attraverso l’espediente della stroboscopia. Il momento terminale della vita di un uomo che trascende nel sogno. Un odissea bulimica di immagini, suoni, colori, armonie, corpi e oggetti condotta, volutamente, fuori sincrono e attraversata da sorpassi epidermici e rappresentazioni stranianti e ardite. La ridondanza dell’inquadratura a plongée che mostra la città dall’alto e la fa apparire un gigantesco flipper in cui le vite degli esseri umani sono sbattute a destra e a manca come palline impazzite. Enter the Void è tutto questo e molto di più: non sempre coerente, talvolta narcisisticamente compiaciuto, altre volte caotico e noioso (le infinite peregrinazioni notturne della m.d.p.), gratuitamente provocatorio, come quando mostra il feto abortito o come quando mette in scena il punto di vista impossibile dell’orgasmo, ossessivo e monomaniacale nella sua durata interminabile, eppure maledettamente affascinante, al punto da divenire un esperienza visiva che con il cinema a poco o nulla a che spartire. Questo perchè le provocazioni passano in secondo piano di fronte ad una forma frastornante, ipnotica e ottundente che come un bad-trip penetra nelle viscere della mente e percorre i “fiumi di porpora” del corpo, costruendo una sinfonia di colori, lisergica e distopica, trasformando l’esistenza terrena in una sorta di interferenza permanente interposta tra un susseguirsi (potenzialmente infinito) di stati mentali e di vite (ri)vissute in dimensioni parallele.